 Il dettato è una delle pratiche didattiche più resistenti nella scuola primaria di lingua italiana. Oggi, come ieri, la maggior parte dei docenti detta; è un dato di fatto. Ma i pareri circa l’utilità del dettato sono anche molto discordanti. E a volte manca una vera consapevolezza riguardo al suo utilizzo.
Il dettato è una delle pratiche didattiche più resistenti nella scuola primaria di lingua italiana. Oggi, come ieri, la maggior parte dei docenti detta; è un dato di fatto. Ma i pareri circa l’utilità del dettato sono anche molto discordanti. E a volte manca una vera consapevolezza riguardo al suo utilizzo.
Già, a che cosa serve il dettato? Molti pensano che serva a imparare a scrivere; molti altri a imparare l’ortografia; qualcuno pensa che non serva a niente di tutto ciò, e che in fin dei conti sia soltanto una tortura alla quale vengono sottoposti milioni di bambini, senza possibilità di scampo.
E allora, di fronte a questi dubbi, a questi pareri discordanti, la cosa migliore da fare è mettersi a studiare vizi e virtù di questa pratica didattica in modo rigoroso e scientifico, per sgombrare il campo da equivoci e luoghi comuni. Come ha fatto Elisa Farina, insegnante di sostegno nella Scuola primaria che ha conseguito il dottorato in Scienze della Formazione e della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ateneo presso il quale collabora. I risultati della sua lunga ricerca sono illustrati nel volume Il dettato nella scuola primaria. Analisi di una pratica di insegnamento, edito dalla FrancoAngeli nel 2014. Una lettura obbligata per ogni docente di scuola primaria.
Che cosa ci dice Elisa Farina, nel suo lavoro? Tante e utili cose, a partire da ciò che avviene in classe quando si detta: ad esempio, che cosa fanno i bambini, che cosa fanno i docenti, in che modo dettano, in che modo danno “istruzioni” (consapevolmente o inconsapevolmente) agli allievi, e quali effetti hanno queste istruzioni sui bambini stessi. E, di conseguenza, ci dice quali regolazioni andrebbero messe in pratica perché il dettato serva davvero a qualcosa.
La mia opinione è sostanzialmente in linea con quella di Elisa Farina, soprattutto quando chiarisce che, per essere efficace, il dettato non dovrebbe essere inteso e praticato solo in senso tradizionale, ma in una molteplicità di varianti (molte delle quali descritte nelle pagine del suo libro) molto più coinvolgenti e cariche di senso rispetto alla sola che molti conoscono. Qualche esempio? Dettare brani estratti dai libri di lettura, dettare un riassunto delle cose apprese alla fine della lezione, dettare all’adulto (invertendo i ruoli), dettare (perché no?) la lista delle cose da fare, o della spesa, o le regole di un gioco, o gli ingredienti di una ricetta, dettare di corsa, dettare i compiti, dettare domande da trasformare in affermazioni, e tanto altro ancora…
E sono allineato con lei ancor più quando scrive che l’insegnamento dell’ortografia può trovare la sua piena e migliore realizzazione quando è inserito nel più vasto tema dell’apprendimento della lingua scritta, e in particolare nella fase cruciale della revisione del testo, che da sempre è uno dei processi della scrittura più trascurati a scuola, e che invece andrebbe collocato ai primissimi posti delle preoccupazioni dei docenti.
Per saperne di più, ovviamente, non posso che rinviare alla lettura dell’ottimo libro, concludendo che, a mio parere, il dettato ha ancora ragion d’essere nella scuola primaria del terzo millennio, a patto che sia usato in modo consapevole e in forme e modalità diverse da quella tradizionale, il cui ricorso andrebbe limitato a non troppo insistenti momenti di verifica (sempre che non si detti sillabando o comunque con intonazioni che suggeriscano ai bambini i luoghi di difficoltà).
In questo modo, il dettato può diventare un prezioso alleato per l’apprendimento, liberandosi dalla zavorra che si porta dietro da decenni: quella che lo associa al terrore per l’errore commesso. I bambini che imparano a scrivere devono sapere che si può (e si deve anche) sbagliare, perché solo sbagliando si diventa consapevoli delle mille sfaccettature di questa complicata lingua italiana. In fondo, è ciò che ci ha insegnato Gianni Rodari, con la sua teoria dell’errore creativo: l’errore può essere bello (come la torre di Pisa!).
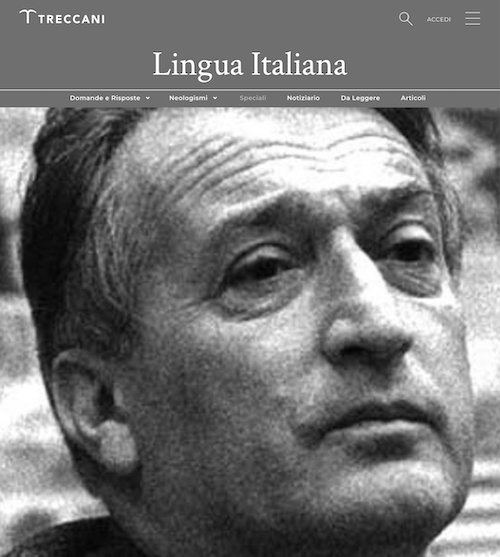



 Il dettato è una delle pratiche didattiche più resistenti nella scuola primaria di lingua italiana. Oggi, come ieri, la maggior parte dei docenti detta; è un dato di fatto. Ma i pareri circa l’utilità del dettato sono anche molto discordanti. E a volte manca una vera consapevolezza riguardo al suo utilizzo.
Il dettato è una delle pratiche didattiche più resistenti nella scuola primaria di lingua italiana. Oggi, come ieri, la maggior parte dei docenti detta; è un dato di fatto. Ma i pareri circa l’utilità del dettato sono anche molto discordanti. E a volte manca una vera consapevolezza riguardo al suo utilizzo. Lo scrittore americano Stephen King, in un suo saggio del 1981 sull’arte di scrivere libri dell’orrore (Danse macabre, ed. it. Theoria, 1992), ha parlato dello sguardo adulto spiegando che, con il passare degli anni, esso si restringe sempre più, provocando quella visione “a tunnel” che ci impedisce di guardare il mondo con lo sguardo aperto del bambino. Ecco le sue parole: “La mia idea della crescita è che il processo consista essenzialmente nello sviluppo di una visione ristretta delle cose, come se la mente entrasse in un tunnel, e in una graduale ossificazione della facoltà immaginativa”. Come dargli torto? Sappiamo bene che i bambini, invece, vedono il mondo con una mente molto più aperta, pronta a cogliere i legami inaspettati tra le cose, disposta in maniera del tutto naturale a compiere viaggi di fantasia, in cui anche un banalissimo oggetto (una sedia, una scatola, un sasso) può diventare qualcosa di magico.
Lo scrittore americano Stephen King, in un suo saggio del 1981 sull’arte di scrivere libri dell’orrore (Danse macabre, ed. it. Theoria, 1992), ha parlato dello sguardo adulto spiegando che, con il passare degli anni, esso si restringe sempre più, provocando quella visione “a tunnel” che ci impedisce di guardare il mondo con lo sguardo aperto del bambino. Ecco le sue parole: “La mia idea della crescita è che il processo consista essenzialmente nello sviluppo di una visione ristretta delle cose, come se la mente entrasse in un tunnel, e in una graduale ossificazione della facoltà immaginativa”. Come dargli torto? Sappiamo bene che i bambini, invece, vedono il mondo con una mente molto più aperta, pronta a cogliere i legami inaspettati tra le cose, disposta in maniera del tutto naturale a compiere viaggi di fantasia, in cui anche un banalissimo oggetto (una sedia, una scatola, un sasso) può diventare qualcosa di magico.